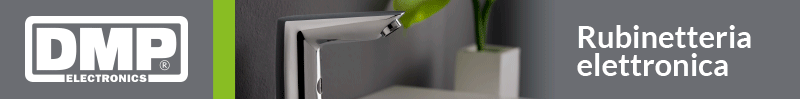Stanno gradatamente spegnendosi gli echi (ed i frastuoni) del Congresso Mondiale sulle famiglie di Verona, ma non credo si superino facilmente i modelli identitari (falsamente identitari) che hanno determinato una spettacolarizzazione in quel territorio del Veneto.
Quali le parole che hanno avuto maggiore richiamo? Evidentemente quelle di “mamma”, poi anche di “moglie”, quindi anche di “figlia” per proseguire con “compagna” e concludere con “amante”.
Fermiamoci un attimo a riflettere: cosa rappresentano questi termini? Fanno riferimento a dei ruoli che la donna può assumere e svolgere, nello stesso periodo e in simultaneità.
Ciò che però merita di essere sottolineato è che sono definizioni che permettono alla donna di esistere e di avere un pubblico riconoscimento, ma pagando lo scotto di cedere una parte (ma in molti casi la totalità) della propria identità di genere.
Ne consegue che spesso questi ruoli somigliano a “ciambelle di salvataggio” della serie: io così come sono, non rappresento nessuno e nulla, ma se sono individuata come “figlia di…” o “moglie di…” o “madre di…”, allora la situazione cambia.
Ciò significa che la donna si percepisce, solo se completata da un ruolo: quale effetto ha tutto ciò? Che il ruolo, se le attribuisce un riconoscimento, al tempo stesso la mutila della sua identità, che storicamente ha sempre avuto difficoltà per emergere. Basti pensare alla considerazione che la società ha verso la “vedova” che resta sempre tale e quindi viene percepita come “mancante” di una parte che risulta per lei completante.
La cosiddetta “ruolizzazione” va poi misurata in riferimento all’IO e se, percentualmente il ruolo di moglie assume una predominanza che va ben oltre il 50%, questo significa che la identità viene perduta e la significatività corrisponde ala propria funzione coniugale ( o a quella filiale, o a quella materna, ecc.).
Né occorre, per le considerazioni fin qui esposte, che la donna debba rivendicare la sua “identità a prescindere (dai ruoli)” attraverso cortei e manifestazioni di rivendicazione della propria autosufficienza: non che tali azioni e mobilitazioni non siano state proficue, ma se si considera che il femminismo è nato negli anni ’70 e la donna questa autoconsapevolezza tutt’oggi l’ha conquistata solo parzialmente, c’è di che preoccuparsi.
Esistono infatti degli “agganci” alla figura maschile così pervasivi, che tuttora la donna continua a viversi come sottomessa, come disposta a subire, come tollerante “per i figli” o “per sé stessa” anche quando le avvisaglie sono talmente inquietanti ed evidenti (in termini di aggressività del marito o del compagno) che il distanziamento da lui dovrebbe essere un comportamento conseguente.
Né il femminismo ha saputo dare una continuità alla sua azione, soprattutto adesso che, con raccapriccio, registriamo numeri assurdi di femminicidio: un delitto che si ripropone in modo sistematico ogni due, tre giorni!
La donna deve raggiungere una consapevolezza di sé che la ponga al riparo da simili soggezioni o da tali sudditanze: raggiungerà tale presa di coscienza di sé a condizione che sappia disidentificarsi dai ruoli aggiuntivi, che la caratterizzano, ma non la determinano.
La disidentificazione è un percorso lungo, in quanto implica che la donna riesca ad autogestirsi senza fare ricorso alla protezione o alla tutela di qualcuno.
Un Paese degno di essere definito civile non può e non deve lasciare che la donna, per salvaguardarsi, debba essere emanazione di un uomo, padre o marito o compagno che sia, perché questo genere di simbiosi è all’origine di molti episodi drammatici:
che sono di nascondimento della sua autenticità in quanto non può esprimersi in libertà, dal momento che “deve rendere conto di sé a qualcun altro”;
che sono espressione di attentati alla sua incolumità in quanto la donna, quando riesce a rendersi conto di aver ceduto parte della sua sovranità in cambio di una tutela non civica, ma familistica e percepisce di subire condizionamenti che la imprigionano e non le sta più bene finendo per ribellarsi, “paga” anche con la vita questa sua “insubordinazione ”.
La consapevolezza di sé è un itinerario lungo, ma a mio parere non ancora intrapreso, anche perché quando è stato avviato, è andato incontro ad “abbagli” che hanno contribuito a deviarne il percorso.
Il Congresso Mondiale della famiglia di Verona, sarà stato così provocatorio da aver suscitato questa azione di riconquista, nella donna, della sua interiorità al punto da aver compreso che, solo liberandosi di ruoli che l’hanno fino ad ora definita, può accedere alla sua libertà?
Una speranza, un auspicio, una opportunità… anche per il mondo maschile!
di Ernesto Albanello